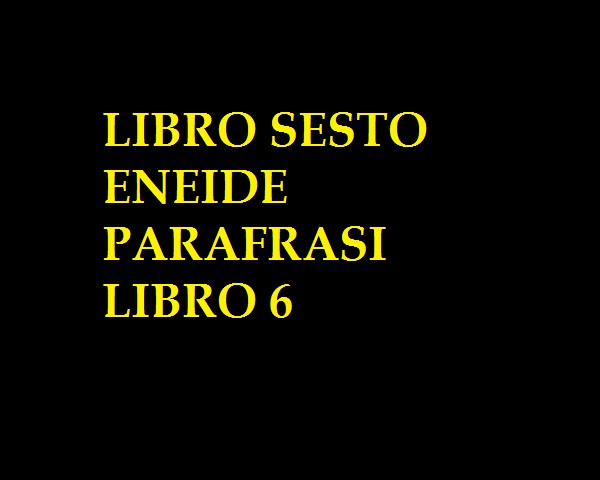LIBRO SESTO ENEIDE PARAFRASI LIBRO 6
-Così dice piangendo; e a tutte vele approda finalmente alle spiagge euboiche di Cuma. Girano verso il mare le prore, le poppe ricurve coprono tutto il lido: con dente tenace l’ancora tiene ferme le navi. Un gruppo di giovani balza ardente sul lido d’Esperia: alcuni accendono il fuoco, percuotendo le selci, sprigionando i semi della fiamma nascosti nelle vene del sasso; altri percorrono le selve, folti asili di fiere, e segnalano le sorgenti trovate. Ma il pio Enea s’incammina verso la rocca, dove l’alta statua d’Apollo domina, verso l’antro immenso e i recessi della tremenda Sibilla alla quale il profetico Nume ispira la mente con la sua volontà, svelandole il futuro. Già s’avvicina al bosco di Trivia e ai tetti d’oro. Dedalo, dice la fama, fuggendo dai regni Minoici, audacemente affidatosi al cielo su penne veloci, volò verso le gelide Orse per un insolito cammino e leggero alfine si fermò sulla rocca calcidica. Appena reso alla terra ti consacrò, o Apollo, i remi delle ali e un grande tempio ti eresse. Sulle sue porte c’è effigiata nell’oro la morte di Androgeo; ci sono gli Ateniesi obbligati ogni anno a pagare un pietoso tributo: sette giovani tirati a sorte. Di contro si leva alta dal mare la terra di Cnosso: si vede l’amore bestiale del toro, Pasifae sottoposta a quel toro in un simulacro di vacca, e il Minotauro, razza mista e biforme, frutto di un empio accoppiamento; e c’è l’inestricabile Labirinto che Dedalo, pietoso dell’amore d’Arianna, dipanò guidando con un filo i passi di Teseo. Icaro, avresti anche tu gran parte in quest’immenso lavoro se il dolore l’avesse consentito. Dedalo aveva tentato due volte di scolpire nell’oro la sua morte; due volte le mani gli caddero. Enea avrebbe guardato a lungo ogni cosa con molta attenzione se Acate, andato avanti, non fosse tornato insieme a Deifobe di Glauco, sacerdotessa di Febo e di Diana. Deifobe gli dice:
Un brivido corse per le ossa dure dei Troiani ed Enea dal profondo del cuore levò questa preghiera: “Apollo, tu che sempre hai avuto pietà dei travagli di Troia, che dirigesti i dardi e le mani di Paride contro il corpo di Achille, che mi sei stato guida per tanti mari che bagnano terre immense, tra genti come i Massili cacciati in luoghi fuori del mondo, per campi come quelli posti lungo le Sirti: ora che finalmente abbiamo toccato le spiagge della sfuggente Italia, fa’ che la mala sorte di Troia non ci segua più oltre! Ormai è giusto che anche voi tutti, Dei e Dee, ai quali Troia e la gloria troiana spiacquero, risparmiate la mia povera gente. Tu, santa profetessa presaga del futuro (io non ti chiedo un regno che il destino non m’abbia già concesso), assicurami che i Teucri e i loro erranti Lari e le travagliate Divinità di Troia troveranno una sede nel Lazio. Leverò allora a Febo e a Trivia un tempio tutto marmo e istituirò dei giorni festivi dedicati al gran nome di Apollo.
E anche tu, sacra vergine, nel nostro impero avrai
un santuario, dove serberò i tuoi oracoli
– i libri sibillini, i destini segreti
che avrai dato al mio popolo – e dove officeranno uomini scelti. Solo, non affidare alle foglie le sacre profezie; potrebbero volarsene via alla rinfusa, trastullo dei rapidi venti. Ti prego, vergine santa, parla tu, di persona.” Ribelle all’ossessione del Dio la profetessa mostruosamente infuria nella caverna, simile a una baccante, e tenta di scacciare dal petto con ogni sforzo l’immenso Febo: ma sempre più il Dio le tormenta la bocca rabbiosa domandone il cuore selvaggio, e le imprime la propria volontà. E già le cento grandi porte della caverna si sono spalancate spontaneamente, portando nell’aria i vaticinii della sacerdotessa: “O tu, che finalmente hai superato i grandi pericoli del mare (ma la terra ti serba pericoli più gravi): i Teucri arriveranno nel regno di Lavinio, bandisci dal tuo petto questa preoccupazione, ma vorranno non esserci mai arrivati. Vedo guerre, orribili guerre, e il Tevere schiumoso di sangue. Avrai lo Xanto e il Simoenta, avrai dei nuovi accampamenti dorici; ed è già nato a difesa del Lazio un altro Achille, figlio anch’egli di una Dea. Giunone si unirà ai nemici dei Teucri, sempre. Quante città e popoli d’Italia andrai a supplicare umile nel bisogno! Una moglie straniera sarà ancora la causa di tanto danno, ancora nozze straniere…
Tu non cedere ai mali, affrontali con più audacia di quanto la tua sorte non lo permetta. La via della salvezza – lo credi? – sarà una città greca.” La Sibilla cumana predice così dal fondo del santuario tremendi responsi ambigui, e mugghia nell’antro mascherando con oscure parole la verità: così Apollo scuote i freni alla donna infuriata e le ficca gli sproni nell’affannoso petto, la stimola e sconvolge. Quando cessò quel furore e la bocca rabbiosa finalmente ebbe pace, Enea le disse: “Vergine, non c’è nessuna fatica che mi giunga inattesa o che mi sembri nuova; ho previsto già prima tutto, ho già soppesato tutto nella mia anima. Ti chiedo solo una cosa: poiché si dice che qui sia la porta del re dell’Inferno e l’oscura palude dove sbocca il gorgo dell’Acheronte, concedimi di andare da mio padre e vedere il suo volto sereno. Insegnami tu la strada, aprimi tu le sacre porte. Lo presi in spalla (su queste spalle!) attraverso le fiamme, attraverso una nube di frecce, lo salvai tra i nemici. Egli, benché fosse invalido, seguendo il mio viaggio, sopportò insieme a me le lunghe traversate del mare e le minacce del cielo e delle onde, oltre le proprie forze e la propria vecchiaia. E fu lui stesso a darmi il comando preciso di venire da te, di arrivare umilmente alla tua soglia. Ti prego, vergine sacra: pietà e del figlio e del padre; tu che puoi tutto, tu che Ecate non per nulla prepose ai boschi d’Averno! È pur vero che Orfeo poté evocare l’Ombra di Euridice, aiutandosi con le corde sonore della sua cetra; è vero che Polluce poté riscattare il fratello dalla morte, morendo a turno, e tante volte fa e rifà questa via. E perché ricordare l’impresa di Teseo e quella d’Ercole? Anch’io discendo dal sommo Giove.” Pregava così stendendo le mani sull’altare; e la sacerdotessa disse: “Sangue divino, Troiano figlio d’Anchise, è facile calare all’Averno: la porta dell’oscura dimora di Dite è sempre aperta, il giorno e la notte. Ma tornare sui propri passi, risalire all’aria che si respira in terra, è faticoso e difficile. Pochi han potuto farlo: figli di Dei, diletti e favoriti da Giove, o animosi, elevati da un ardente valore sino all’altissimo cielo. Lo spazio di qui a Dite è occupato da dense foreste, che Cocito circonda di neri meandri. Se davvero desideri con tanta forza passare due volte le paludi dello Stige, vedere due volte il nero Tartaro, se davvero hai il coraggio di tentare un’impresa pazzesca, ascolta quello che prima dovrai fare. Sopra un albero ombroso, opaco, pieno di foglie, c’è un ramo tutto d’oro (d’oro le foglie, d’oro il flessibile gambo) consacrato a Giunone infernale: lo copre e lo nasconde il bosco, un’alta ombra lo chiude in una valle oscura. Non si può penetrare nei segreti del suolo prima d’aver strappato dall’albero quel ramo dalle chiome dorate. L’ha deciso la bella Proserpina, che vuole le si porti in regalo il ramo: chi lo strappa ne vede spuntare un altro eguale, mettere fronde di un eguale metallo. Cerca in alto con gli occhi, e quando riesci a trovarlo strappalo con le mani secondo il rito. Il ramo seguirà la tua mano con facilità se i destini ti chiamano; altrimenti non riuscirai a vincerlo neanche col duro ferro. Ma ascolta ancora: un tuo amico giace morto sul lido (e tu lo ignori!) portando sfortuna a tutta la flotta col suo cadavere; mentre interroghi l’oracolo, poni domande e indugi davanti alla mia soglia. Conduci prima quel morto alla sua estrema dimora, componilo nel sepolcro. Immola pecore nere come tua prima offerta espiatoria. Così finalmente vedrai i boschi dello Stige, i regni che non hanno strade per gli uomini vivi.” Enea col volto triste, gli occhi chinati a terra, s’incammina, lasciando la caverna, e rivolge tra sé quei vaticinii oscuri, quegli eventi misteriosi. Con lui il fido Acate muove i passi di conserva, preoccupato da eguali pensieri. Discorrevano nell’andare di molti problemi, domandandosi di che compagno morto e di che sepoltura parlasse la Sibilla. Ma ecco che, arrivati all’accampamento, vedono sul lido asciutto, morto indegnamente, Miseno;
Miseno figlio d’Eolo, il più bravo di tutti a chiamare i guerrieri con la tromba, a infiammare col suono il violento Marte. Era stato compagno del grande Ettore, insieme ad Ettore affrontava le battaglie, famoso per la tromba e la lancia. Dopo che il vittorioso Achille aveva spogliato Ettore della vita, il fortissimo eroe Miseno si era unito al dardanide Enea, seguendo così destini e forze non inferiori. Un poco prima, mentre faceva risuonare con la cava conchiglia i mari, provocando follemente gli Dei a gara, un Tritone invidioso – se è vero quel che si dice – l’aveva travolto di sorpresa in mezzo agli scogli fra le onde spumeggianti. Intorno al suo cadavere si lamentano tutti con molte grida: su tutti il valoroso Enea. E piangendo s’affrettano ad eseguire gli ordini della Sibilla – senza nessun indugio – e gareggiano nell’alzare con tronchi l’altare funerario, levandolo sino al cielo. Vanno in un bosco antico, profondo covo di fiere, e gli abeti rovinano, risuona il leccio percosso dalle scuri, risuonano i frassini, la quercia facilmente fendibile è spaccata coi cunei, rotolano giù dai monti i grandissimi orni. Enea lavora con gli altri, più degli altri, ed esorta i compagni, munito come loro di scure. Intanto col cuore afflitto guarda l’immensa selva pensando al ramo d’oro nascosto chissà dove, e prega: “Oh, se quel ramo a un tratto mi si mostrasse dal suo albero, in mezzo a questo bosco troppo grande. Quello che ha detto di te la profetessa, o Miseno, purtroppo era la verità.”
Aveva appena parlato quando ecco, per caso, due colombe volando dal cielo vennero proprio sotto gli occhi di Enea e andarono a posarsi sull’erba verde del suolo. Il grandissimo eroe riconobbe gli uccelli materni e lieto pregò:
“Oh, siatemi guide sul sentiero segreto, e volando nell’aria dirigete i miei passi attraverso le selve fin dove il ricco ramo fa ombra al fertile suolo! E tu, madre divina, assistimi, ti prego, in questo momento difficile!” Ciò detto si fermò a guardare gli uccelli, dove accennassero a andare, se gli dessero un segno. Le colombe beccarono qui e là, allontanandosi con piccoli voli solo di quel tanto che permettesse a Enea di seguirle con gli occhi. Poi giunte quasi alla gola del puzzolente Averno si levano a volo veloci e scivolando per l’aria limpida vanno a posarsi nel luogo desiderato, sull’albero di dove scintilla luminoso in mezzo ai verdi rami il chiarore dell’oro. Come il vischio, cresciuto da una pianta non sua, durante il freddo invernale verdeggia di fresca e nuova fronda nei boschi deserti e incorona i tronchi rotondi coi frutti colore del croco; così sul leccio scuro splendeva l’oro fronzuto, così la lamina fine squillava nel vento leggero. Enea subito afferra il ramo, avidamente vince la sua durezza, lo porta alla Sibilla. Intanto sulla spiaggia i Troiani piangevano l’eroe Miseno e rendevano all’insensibile salma gli estremi onori. Alzavano un altissimo rogo di rami resinosi di pino e tronchi di quercia, ricoprendone i fianchi di nere fronde: davanti vi piantano cipressi funerari, vi gettano sopra per ornamento le armi scintillanti. Alcuni preparano l’acqua calda e fanno bollire sul fuoco i vasi di bronzo, lavano il corpo freddo e lo ungono di balsami, tra funebri lamenti; coricano sul rogo le membra tanto piante e vi gettano sopra vesti di porpora, gli abiti che soleva indossare. Ed altri si avvicinano al gran feretro (triste compito) con le fiaccole in mano, la faccia voltata, secondo l’uso ancestrale: gli danno fuoco. Bruciano le molte offerte, l’incenso, le carni delle vittime, l’olio sparso a gran tazze. Cadute tutte le ceneri e spentasi la fiamma, lavavano nel vino l’ossa, la brace calda e assetata: in un’urna di bronzo Corineo chiuse i poveri resti. Lo stesso Corineo girò attorno ai compagni per tre volte, tenendo un vaso d’acqua lustrale, spruzzandoli di rugiada leggera con un ramo di pacifico olivo: così li purificò e disse l’estremo saluto. Il pio Enea elevò al guerriero un immenso sepolcro, con le sue armi, il suo remo e la tromba, sotto un aereo monte che dal nome del morto ora si chiama Miseno, e che si chiamerà eternamente Miseno, nei secoli dei secoli. Fatto questo, Enea esegue gli ordini della Sibilla. C’era un’enorme caverna dalla vasta apertura tagliata nella roccia, difesa da un lago nero e dal buio dei boschi. Nessun uccello poteva volarvi impunemente al di sopra, per gli aliti che salivano al cielo convesso, sprigionandosi dalla sua scura bocca. Qui la sacerdotessa fa condurre anzitutto quattro giovani tori dal dorso nero; versa sul loro capo del vino, taglia un ciuffo di peli tra le corna e li getta sui fuochi sacri, prima offerta, chiamando a gran voce Ecate potente nel cielo e nell’Erebo.
Alcuni guerrieri affondano i coltelli nelle gole dei tori e raccolgono il sangue tiepido nelle tazze. Lo stesso Enea ferisce con la sua spada un’agnella dal vello nero, immolandola alla Notte, che è madre delle Eumenidi, e a Gea sua grande sorella, ed una vacca sterile a te, Proserpina. Poi, di notte, leva altari al re dello Stige e pone sul fuoco interi quarti di carne, versando olio sulle viscere ardenti. Ed ecco, al chiarore dell’alba e al sorgere del sole, la terra mugghiò sotto i piedi, le cime dei boschi cominciarono a muoversi e cani parvero urlare traverso l’ombra, man mano che si avvicinava la Dea. “Profani, via di qui! – grida la profetessa.
– Andate via dal bosco! E tu, Enea, sguainando l’acuta spada, avviati sulla strada dell’Ade: adesso è necessario aver coraggio, un cuore risoluto!” Ciò detto furiosa si slanciò nell’aperta caverna, ed egli la raggiunse, seguì con passi fermi i passi della sua guida. Dei che avete l’impero sulle anime, Ombre silenziose, Caos e Flegetonte, luoghi che vi estendete muti in un’immensa notte: mi sia lecito dire quel che ho udito, svelare col vostro consenso le cose sepolte nella terra profonda e nell’oscurità!
Andavano senza luce nella notte solitaria, attraverso la tenebra, attraverso le case vuote, i regni deserti di Dite: come fosse un viaggio per boschi con una luna incerta che filtri appena i suoi raggi avari tra il fogliame, quando Giove ha sommerso il cielo d’ombra opaca e la notte ha privato di colore le cose.
Nel vestibolo, proprio all’entrata dell’Orco,
hanno i loro giacigli il Lutto ed i Rimorsi
vendicatori, e vi abitano le pallide Malattie,
la Vecchiaia tristissima, la Paura e la Fame
cattiva consigliera, la turpe Povertà
– fantasmi tremendi a vedersi -, la Morte e la Sofferenza, i Piaceri colpevoli ed il Sonno, fratello della morte. Di fronte c’è la Guerra assassina, con le stanze di ferro delle terribili Furie, e la folle Discordia, cinta di bende cruente la chioma viperina. In mezzo un olmo immenso, ombroso, stende i rami e le braccia annose: dicono che questa sia la casa dove stanno di solito i vani Sogni, appesi sotto ciascuna foglia. Ma ancora tanti mostri d’apparenza selvaggia bivaccano sulle porte: i Centauri e le Scille biformi, Briareo immane, dalle cento braccia, Chimera armata di fuoco, l’Idra di Lerna che stride orribilmente, le Gorgoni, le Arpie e Gerione, fantasma di tre corpi. Qui Enea, trepido d’improvvisa paura, sguainò la spada presentandone l’acuta punta ai mostri che avanzavano: e se non l’avesse frenato la sua compagna, conscia che quelle vite leggere volano senza corpo e sono mera apparenza, si sarebbe slanciato a percuotere invano con la spada le Ombre. Di là parte la strada che conduce alle onde del tartareo Acheronte. Il suo gorgo è un’immensa voragine, che bolle fangosa e si riversa nel Cocito. Custode di questi fiumi è Caronte, spaventoso nocchiero dall’orrenda sporcizia: bianco foltissimo pelo gli pende incolto dal mento, gli occhi pieni di fiamme stan fissi, stralunati; ha un sudicio mantello legato sulle spalle. Spinge lui stesso la barca con un palo, e governa le vele, traghettando i morti sul bruno scafo: vecchio ma Dio, di fiera e vegeta vecchiezza.
Tutta una folla immensa correva verso le rive:
uomini e donne, corpi di magnanimi eroi usciti di vita, fanciulli e vergini fanciulle, giovani posti sui roghi davanti ai genitori; come le foglie, che cadono a milioni nei boschi staccate dal primo gelo d’autunno, o come gli uccelli che si ammucchiano a schiere fittissime sulla spiaggia venendo dall’alto mare, quando la fredda stagione li spinge oltre l’oceano in paesi assolati. Pregavano di passare per primi quell’acqua, le mani tese nel desiderio della riva di fronte. Ma il triste nocchiero ne sceglie solo qualcuno e scaccia gli altri via dalla sponda sabbiosa.
Enea, stupito e commosso da un tale tumulto, disse:
“Vergine, che vuol dire questo affollarsi al fiume? Che vogliono le anime? E per quale motivo alcune sono costrette a abbandonare la riva mentre le altre coi remi solcano l’onda livida?” La vecchia sacerdotessa gli rispose con poche parole: “Figlio d’Anchise, sicura prole divina, tu vedi gli stagni profondi di Cocito e la Stigia palude, invocata nei grandi giuramenti degli Dei che non possono offenderne la potenza giurando il falso. La folla cacciata via dal fiume sono i morti insepolti, quelli che l’onda porta invece sono sepolti: il nocchiero è Caronte. Non si può attraversare le rive fosche e le roche correnti prima che l’ossa riposino nella tomba. Chi non è seppellito erra per cento anni intorno a questi lidi; poi finalmente è accolto nella barca e rivede gli stagni desiderati.” Enea si fermò attonito, pensando a molte cose, commiserando il destino triste di quelle anime. E vede mesti, privi di onore sepolcrale, Leucaspi e Oronte, capo della flotta di Licia, che mentre navigavano da Troia sui ventosi mari furono entrambi travolti nelle onde dalla bufera, insieme ai compagni e alle navi. Ed ecco farsi avanti Palinuro, il nocchiero, il quale poco prima, nel viaggio dall’Africa, osservando le stelle era caduto in mare giù dalla poppa. Appena Enea ne riconobbe, a fatica, attraverso la fitta oscurità, il mesto volto, gli disse: “Palinuro, qual Dio ti ha rapito e sommerso nell’acqua profonda? Parla! Apollo, che mai ci è sembrato bugiardo, m’ha ingannato soltanto nel tuo caso, poiché aveva detto che tu ti saresti salvato dal mare ed arrivato ai confini d’Ausonia. Ha mantenuto così la sua promessa?” Allora Palinuro rispose: “L’oracolo di Apollo non ti ingannò, né un Dio mi sommerse nel mare, duce figlio di Anchise. Si ruppe per caso il timone a una scossa violenta: io, che gli stavo attaccato come fanno i piloti e dirigevo la nave, cadendo me lo tirai dietro. Credimi, te lo giuro sul mare tempestoso, io non ebbi paura per me ma per la tua nave, che priva di timone e di pilota avrebbe potuto cedere ad onde così grandi. Un violento Noto mi trascinò nel mare per tre notti di tempesta, su immense distese d’acqua; nasceva appena il quarto giorno quando, alzandomi in cima a un’onda lunga, vidi l’Italia. A poco a poco nuotavo verso terra, ed ero già al sicuro se una gente crudele non mi avesse assalito con le armi, accogliendomi, ignara, come una preda, mentre cercavo, impacciato dalla veste bagnata, di afferrarmi agli spigoli taglienti di una rupe con le mani protese. Ora mi tiene l’onda e i venti mi travolgono sulla spiaggia. Perciò ti prego per la cara luce del cielo, per l’aria, per le speranze di Iulo che cresce, per tuo padre, strappami a questi mali, o invitto! Gettami sopra della terra – lo puoi – toccando i porti di Velia. O se c’è il modo, se la tua divina madre ce ne mostra qualcuno (con l’aiuto celeste, io credo, ti prepari a traversare i fiumi e la palude Stigia), dammi la mano, e portami attraverso queste onde, che almeno nella morte io riposi tranquillo!” Ma la sacerdotessa gli disse: “O Palinuro, dove ti viene quest’empio desiderio?
Tu vuoi attraversare insepolto le acque dello Stige ed il fiume severo delle Eumenidi? Vuoi andare senza ordini alla riva proibita? Non sperare che i Fati si muovano a pietà, per quanto tu li preghi! Ma ascolta attentamente le mie parole, ti siano conforto nella disgrazia.
I popoli vicini al tuo nudo cadavere
– turbati da prodigi celesti che avverranno nelle loro città, dovunque – placheranno le tue ossa, elevando una tomba e portandovi vittime sacre: il luogo si chiamerà in eterno Palinuro!” L’annunzio allontanò per un poco il dolore e gli affanni dal cuore rattristato di Palinuro: è lieto di dare il nome a una terra. Procedendo nel loro viaggio, arrivano al fiume. Quando il nocchiero, da oltre l’onda Stigia, li vede muovere attraverso il bosco silenzioso volgendo il piede alla riva, li assale per primo a parole, gridando: “Chiunque tu sia che t’avvicini armato al nostro fiume, fermati dove sei e di là dimmi perché vieni. Qui è il luogo delle Ombre, del sonno, della notte che addormenta. Non si può trasportare dei corpi viventi sulla carena Stigia. Né devo rallegrarmi d’aver accolto sul fiume Ercole, e Piritoo e Teseo, benché fossero di forza invitta e figli di Numi. Di sua mano il primo incatenò il guardiano del Tartaro, lo portò via tremante dal trono di Plutone; e gli altri due cercarono di rapire Proserpina dalla stanza nuziale.”
La profetessa anfrisia rispose brevemente:
“Non abbiamo intenzioni cattive, stai tranquillo, queste armi non portano guerra: lo smisurato portinaio, latrando in eterno dal fondo del suo antro, continui a atterrire le ombre senza sangue; la casta Proserpina continui a custodire in pace la casa di suo zio. Costui è il troiano Enea, famoso per le armi e la pietà, che scende da suo padre tra le ombre più profonde dell’Erebo. Se non ti commuove l’esempio di una tale pietà, almeno riconosci questo ramo!” e mostrò il ramo che teneva nascosto sotto la veste. Il cuore di Caronte, gonfio d’ira, si mise in pace: egli non disse più nulla. Contemplando il dono venerabile del fatale virgulto, che non aveva visto da tanto tempo, il nocchiero volse la poppa bruna, s’avvicinò alla riva. Poi allontanò le anime sedute sui lunghi banchi, sgombrando la corsia per far salire il grande Enea. Cigolò sotto il peso lo scafo mal contesto, imbarcando per le tante fessure l’acqua della palude. Finalmente depose Enea e la profetessa incolumi al di là del fiume, sulla riva densa di fango informe e di glauche erbe acquatiche. Lo smisurato Cerbero rintrona questi luoghi col suo ringhio che esce da tre bocche, sdraiato quant’è lungo in un antro. E la sacerdotessa vedendo i suoi tre colli farsi irti di serpenti gli getta una focaccia affatturata di miele ed erbe soporifere. Spalancando le gole il cane l’afferra con fame rabbiosa e subito, sdraiato a terra, allunga nel sonno la groppa mostruosa, riempiendo tutta la tana. Addormentato il guardiano, superano l’entrata allontanandosi in fretta da quell’acqua fangosa che non si può attraversare una seconda volta. S’udirono subito voci e un immenso vagito; poiché proprio sul limite dell’Ade stanno le anime piangenti dei bambini che un giorno fatale portò via prima ancora che cominciassero a vivere, rapiti al seno materno per essere sommersi in una morte immatura. Accanto a loro ci sono i condannati a morte sotto falsa accusa. Queste dimore infernali non sono state assegnate senza giudizio e giudice: Minosse inquisitore scuote l’urna dei fati, convoca l’assemblea dei morti silenziosi, li interroga, ne apprende i delitti e la vita. Poi vengono, tristi, coloro di null’altro colpevoli che d’essersi data la morte di propria mano, d’avere gettata l’anima per odio della luce. Oh, adesso come vorrebbero patire la miseria e le più dure fatiche nell’alta aria celeste! Ma il destino s’oppone, li incatena la triste palude d’acqua sporca e li serra lo Stige coi suoi nove meandri. Poco più in là si vede, estesa in lungo e in largo, la pianura che chiamano i Campi del Pianto. Qui segreti sentieri nascondono coloro che un amore crudele consumò, ed una selva di mirti li protegge: nemmeno nella morte trovano requie al dolore. Enea vi scopre Fedra, Procre, la triste Erifile che mostra le ferite inflittele dal figlio, ed Evadne e Pasifae; ad esse s’accompagnano Laodamia e Ceneo, divenuta di donna uomo (ma adesso è donna, cambiata dalla morte nella sua antica forma). La fenicia Didone con la ferita ancor fresca s’aggirava nel bosco. Quando l’eroe troiano le fu vicino, e la vide, e la riconobbe, oscura nell’ombra, come chi vede o crede di vedere un’esilissima falce di luna all’inizio del mese sorgere tra le nubi, si sciolse in pianto e le disse con dolce amore: “Infelice Didone, dunque era vera la voce che eri morta, che avevi obbedito al tuo estremo destino col ferro. Ahimè, io sono stato la causa della tua morte? Lo giuro per le stelle e i Celesti, per quel che c’è di più sacro sotto la terra profonda, ho lasciato il tuo lido, regina, mio malgrado. Mi spinsero a fuggire gli ordini degli Dei, che m’obbligano adesso a andare attraverso le ombre per un cammino spinoso e un’altissima notte; non avrei mai creduto di darti un tale dolore partendo da Cartagine. Fermati, non sottrarti alla mia vista! Chi fuggi? Questa è l’ultima volta, per volere del Fato, che io posso parlarti.” Così Enea cercava di calmare quell’anima ardente di furioso dolore, dagli sguardi torvi, e piegarla al pianto. Ma Didone, girando la testa, teneva gli occhi fissi sul suolo, senza commuoversi in volto per quel discorso, più che fosse un’aspra selce o una rupe di Marpesso. Infine scappò via, si rifugiò sdegnata nel bosco ombroso, dove il primo marito Sicheo condivide i suoi affanni e ricambia il suo amore. Ma Enea la seguì in lagrime per lungo tratto, mentre s’allontanava, pietoso, dolente della sua sorte. Poi continuò il viaggio che gli era stato consentito. Arrivavano già ai campi più remoti, appartati, ove vivono gli uomini illustri in guerra; e qui gli vennero incontro Tideo, Partenopeo famoso nelle armi, il fantasma di Adrasto pallido e i Troiani caduti in battaglia e molto pianti in terra. Ne vide una lunga fila:
Glauco, Medonte, Tersiloco, i tre figli d’Antenore, Ideo che ancora reggeva il suo cocchio e le armi, e Polibete sacro a Cerere. Gemette nel vederli. Frementi le anime s’accalcano intorno a lui, a sinistra e a destra. Non contente di vederlo una volta, indugiano e s’accostano per sapere il motivo per cui era venuto. Ma i capi greci e le schiere di Agamennone, quando scorsero l’eroe vivo e le armi spendenti attraverso la notte, tremarono di paura: alcuni fuggirono come un tempo allorché trovarono scampo sulle navi, altri emisero una debole voce, ma il grido incominciato si spense nelle bocche invano spalancate. E vede anche Deifobo, figlio di Priamo, straziato nel corpo, mutilato crudelmente nel viso, con le mani tagliate, le orecchie strappate, il naso reciso da una turpe ferita.
Lo riconosce a stento, poiché tremando cela coi moncherini le atroci cicatrici. Gli dice:
“Valoroso Deifobo, nato dal grande sangue di Teucro, chi ti inflisse pene così crudeli? Chi poté osare tanto contro di te? Mi dissero che nell’ultima notte di Troia eri caduto su un mucchio di confusi cadaveri, stremato dalla gran strage di Greci. Allora ti elevai una tomba vuota sul lido del capo Reteo, poi tre volte ho invocato a gran voce i tuoi Mani. Quel luogo è segnato dal nome e dalle armi di Deifobo. Amico, non potei rivederti, né seppellirti partendo in terra natia!” Il figlio di Priamo risponde: “Non hai dimenticato nulla, amico, hai assolto ogni dovere funebre verso Deifobo e verso l’Ombra del suo cadavere. Il mio destino e le colpe di Elena di Sparta m’han gettato in un mare di dolori, m’han dato queste ferite in ricordo. Tu lo sai bene come passammo l’ultima notte di Troia tra ingannevoli gioie: è duro rammentarlo ma necessario. Quando il cavallo fatale venne d’un balzo sull’alta Pergamo, pesante, col ventre pieno d’armati, Elena fece finta di guidare un coro, celebrando l’orgia, seguita dalle Troiane: ma, levando una fiaccola in mezzo al coro, mandava segnali ai Greci, chiamandoli dall’alto della rocca. Io mi sdraiai sul letto vinto dalle emozioni ed oppresso dal sonno, e mi assalì una quiete dolce e profonda, simile a una placida morte. Quell’eccellente moglie mi porta via di casa tutte le armi e mi leva la spada di sotto al capo; poi chiama il primo marito Menelao e spalanca le porte, consegnandogli in dono la mia testa, sperando di ingraziarselo e cancellare così l’antico tradimento.
In breve: irrompono tutti e due nella stanza in compagnia di Ulisse, maestro di delitti. O Dei, se è giusto ch’io chieda vendetta, ricambiate queste scelleratezze ai Greci, colpo per colpo! Ma tu, Enea, raccontami come sei giunto qui da vivo. Forse vieni per ordine divino o spinto dal lungo errare sul mare? Quale disgrazia ancora ti sconvolge tanto da farti scendere al fosco paese, alle case dolenti, prive di luce?” Mentre parlavano l’Aurora dalla quadriga rosata aveva già corso metà del suo itinerario celeste. E avrebbero forse perduto così l’intero tempo accordato al viaggio se la sacra Sibilla non avesse ammonito il suo compagno, dicendo:
“Enea, già cade la notte, e noi passiamo le ore a piangere. Eccoci al punto dove la via si biforca: a destra c’è la strada che porta alle mura di Dite e che dobbiamo seguire per andare all’Eliso; a sinistra c’è il luogo dove sono puniti i malvagi, la strada che porta all’empio Tartaro.” Le rispose Deifobo: “Grande sacerdotessa, non t’arrabbiare, andrò via, tornerò ad ingrossare il numero delle Ombre, sparirò nelle tenebre. E tu, Enea, nostra gloria, va’! Verso migliori destini.”
Altro non disse e tornò indietro nella notte. Enea si volta e vede all’improvviso, a sinistra, sotto una roccia, un’immensa città, circondata da tre cerchi di mura; un fiume vorticoso, il Flegetonte, la cinge con le sue acque di fuoco che trascinano massi risonanti. Di fronte c’è una porta grandissima, e colonne d’acciaio che nessun uomo e nemmeno gli stessi Dei potrebbero spezzare. E c’è una torre altissima, di ferro, su cui siede Tisifone, la veste insanguinata, custode sempre insonne dell’atrio, giorno e notte. Si sentono venire di là pianti, crudeli colpi di frusta, stridore di ferro e di catene trascinate. Atterrito da quel frastuono Enea si fermò ad ascoltare: “Sacra vergine, parla: che sorta di delitti sono puniti laggiù? Che pene opprimono i miseri peccatori? Che pianto si leva?” La profetessa gli rispose: “Famoso duce dei Teucri, agli uomini senza colpe è proibito battere a quella porta scellerata; ma Ecate m’insegnò le pene divine e mi condusse dovunque quando mi mise a capo dei boschi dell’Averno. Radamanto di Cnosso presiede a questi regni terribili: e castiga, confessa, costringe chi da vivo ha peccato a espiare i delitti che tanti son riusciti a tenere nascosti sino alla tarda morte, lieti del vano inganno. Tisifone vendicatrice, munita di una frusta sferza quei peccatori e li insulta, agitando con la sinistra torvi serpenti: poi chiama le crudeli sorelle. Allora finalmente le porte maledette si aprono, stridendo sui cardini con suono orrendo. Riesci a vedere che sconvolgente figura siede nell’atrio? Chi custodisce le porte? È Tisifone. E dentro, ancora più feroce, c’è l’Idra spaventosa, enorme, con cinquanta bocche spalancate. Poi si apre a precipizio il Tartaro e s’inabissa sotto le ombre, due volte più profondo del cielo che a perdita d’occhi s’alza sino all’Olimpo. Rotolano laggiù, piombativi dal fulmine, i Titani, la prole antica della Terra.
Vi ho visto Oto e Efialte dai corpi immani, che vollero distruggere il cielo, cacciare Giove dall’alto regno. Vi ho visto punito Salmoneo, che imitava le folgori di Giove, il tuono dell’Olimpo. Trascinato da quattro cavalli, scuotendo una face, andava trionfante tra i popoli greci e nella sua città posta al centro dell’Elide, reclamando per sé gli onori divini: cercava follemente di imitare, col rombo del suo carro di bronzo e col galoppo serrato dei cavalli dall’unghia di corno, le tempeste e il fulmine che non si può imitare. Ma Giove onnipotente, irato, di tra le nuvole nere gli scagliò un vero fulmine (ben diverso dai tizzi dalla fiamma fumosa che Salmoneo agitava) e lo tuffò a capofitto in un immenso turbine. E c’è anche Tizio, figliolo della Terra madre di tutto, il cui corpo è lungo nove jugeri. Un enorme avvoltoio gli scava dentro il fianco col becco adunco, rodendogli il fegato immortale, le viscere dolenti: s’annida nel suo petto e non dà tregua alle fibre che rinascono sempre. Sopra i Lapiti, Issione e Piritoo, è sospeso un masso nero che sembra stia lì lì per cadere. Splendono i piedi d’oro di letti sontuosi, son preparati banchetti con lusso regale: vicino al peccatore è sdraiata una Furia, la maggiore di tutte, non gli lascia toccare con le mani le mense, e si leva tenendo una fiaccola in pugno, grida con voce di tuono. Qui stanno coloro che odiarono in vita i fratelli, o picchiarono i loro padri, o ordirono frodi ai loro clienti, o stettero a covare da soli le ricchezze riunite (sono i più) senza dividerle coi propri parenti; ci sono gli uccisi per adulterio, e coloro che presero parte a guerre sacrileghe, o tradirono la fede giurata ai padroni: rinchiusi qui scontano la pena. Non cercar di sapere quale sia questa pena, quale sorte o delitto abbia sommerso là quegli uomini. C’è chi rotola sassi enormi, o è appeso, legato, ai raggi d’una ruota. L’infelice Teseo sta seduto e in eterno starà seduto; Flegias grida a tutta voce attraverso le ombre:
‘Il mio esempio vi insegni ad essere giusti;
a non disprezzare gli Dei!’ C’è chi vendette
la patria per denaro e le impose un tiranno
dispotico; chi fece e disfece leggi
per denaro; c’è chi incestuoso violò
la figlia, consumò nozze illecite: tutti pensarono e compirono qualcosa di tremendo. Se avessi cento lingue, cento bocche, una voce di ferro non potrei parlarti di tutti i delitti e passare in rassegna tutte le varie pene.” Ciò detto la vecchia sacerdotessa di Febo soggiunse: “Ma via, riprendi il cammino, compi il dovere intrapreso. Affrettiamoci, vedo di fronte a noi le mura uscite dalle officine dei Ciclopi e la porta dove dobbiamo lasciare il ramoscello d’oro per la grande Proserpina.” Avanzarono insieme nel buio delle vie avvicinandosi in fretta alla porta. Il pio Enea raggiunse l’entrata e, spruzzatosi d’acqua allora attinta, affisse il ramo sulla soglia. Fatto questo, adempiuto il voto alla Dea, giunsero ai luoghi felici, al verde ameno dei boschi fortunati, al soggiorno dei beati. Qui un’aria più libera avvolge i campi di luce purpurea, ci sono stelle e un sole. Qualcuno dei beati si esercita sull’erba in gare sportive o lotta sulla fulva arena; qualcun altro canta dei versi o danza in coro. Il tracio Orfeo con una lunga veste fa risuonare le sette corde della sua cetra, toccandole con le dita o con un plettro d’avorio. Riposano qui in eterno Ilo, Assaraco e Dardano fondatore di Troia, eroi magnanimi, nati in un’età migliore, antica stirpe di Teucro, razza meravigliosa.
Enea ammira le armi e i carri dei guerrieri:
vuote apparenze. Le lance stanno piantate in terra ed i cavalli sciolti pascolano per il prato. Ora che sono morti hanno lo stesso amore per i carri e le armi, e la stessa passione d’allevare i cavalli che ebbero da vivi.
Poi ne vede molti altri a destra e a sinistra:
banchettano sull’erba cantando in coro un inno di gioia, in mezzo a un bosco profumato d’alloro per dove scorre il fiume Po, ricco d’acque, e sale verso la terra. Qui dimorano gli eroi che furono feriti combattendo per la patria, i sacerdoti casti, i poeti che scrissero versi degni di Apollo, gli inventori delle arti adatte a ingentilire la vita, e coloro che bene meritarono la memoria dei posteri: le tempie incoronate da una benda di neve. La Sibilla parlò a quelle Ombre, che intorno le si accalcavano, e chiese a Museo che vedeva torreggiare sugli altri più alto e più autorevole:
“Anime care e tu, grande poeta, diteci, dov’è Anchise? Per lui siamo venuti qui, abbiamo attraversato i grandi fiumi dell’Erebo.” E l’eroe le rispose: “Nessuno di noi ha un posto fisso; stiamo nei boschi ombrosi, sul bordo dei fiumi e nei prati freschi di ruscelli. Ma se cercate Anchise, superate quel colle laggiù, vi guiderò su una facile via.” Li precedette mostrando dall’alto i campi lucenti; ed essi subito scesero la china della collina.
Frattanto Anchise guardava con dolce attenzione
le anime racchiuse nel fondo di una valle
erbosa: destinate a venire alla luce
sulla terra. Così passava in rassegna
i suoi futuri nipoti, le loro sorti fatali, i costumi e le imprese. Appena vide Enea che gli veniva incontro attraverso il bel prato gli tese le mani piangendo di gioia:
“Finalmente sei giunto, la tua pietà – che tanto ho aspettato – ha potuto vincere le durezze del cammino? Ti vedo, sento la nota voce, posso parlarti, figlio! Speravo di vederti e calcolavo il tempo: né la trepida attesa m’ha ingannato. Attraverso quali terre, attraverso quanti mari portato, da quanti pericoli sbattuto, o figlio, ti accolgo! E quanto ho temuto i pericoli del regno della Libia!” E l’eroe: “La tua Ombra dolente, tante volte veduta in sogno, mi spinse a venire quaggiù: le mie navi son ferme sul Tirreno. Deh, lasciami prendere la tua mano! Non sottrarti al mio abbraccio!” Così dicendo bagnava le gote di pianto. Tre volte cercò di gettargli le braccia al collo, tre volte l’Ombra, invano abbracciata, gli sfuggì dalle mani simile ai venti leggeri o ad un alato sogno. Nella valle appartata Enea vede una selva solitaria, fruscianti virgulti e il fiume Lete che bagna quel paese di pace. Intorno ad esso si aggiravano popoli e genti innumerevoli: così nell’estate serena le api si posano sui fiori colorati e sui candidi gigli e tutta la pianura risuona del loro ronzio. Enea stupisce alla vista improvvisa e ne chiede il significato, che fiume sia quello laggiù, chi siano le anime che affollano le rive. E Anchise: “Coloro cui tocca incarnarsi una seconda volta, bevono al Lete un’acqua che fa dimenticare gli affanni, un lungo oblio. Ma è tanto che desidero mostrarti, una per una, le anime che un giorno saranno i miei discendenti; così sempre di più potrai rallegrarti d’aver raggiunto l’Italia.” “Padre, dobbiamo credere che ci siano delle anime che fuggono di qui per salire nell’aria terrestre e ritornare di nuovo nei pesanti corpi? Che desiderio insensato di vita possono avere, infelici?” Allora Anchise gli spiega ogni cosa, per ordine. “Dapprima uno spirito vivifica dall’interno cielo, terra, le liquide distese marine, il sole titanio, il globo lucente della luna: una mente diffusa per le membra del mondo ne muove l’intera mole, si mescola con la sua massa. Nascono da esso le razze degli uomini e degli animali, le vite dei volatili, i mostri che il mare produce sotto la sua superficie lucente come il marmo. In tali semi di vita c’è un’energia di fuoco, una celeste origine: ma i corpi, questi pesi nocivi li rendono lenti, le membra mortali e gli organi terreni li ottundono. Perciò sono soggetti al timore e al desiderio, al dolore e alla gioia; rinchiusi nel buio carcere del corpo non riescono a vedere il cielo. Neanche quando nel giorno supremo la vita le ha lasciate quelle povere anime riescono a liberarsi di tutti i mali e di tutte le brutture del corpo: tanto i peccati han messo radici profonde. Così sono soggette a pene e riscattano le colpe antiche. Alcune sospese per aria sono investite dai soffi del vento; altre lavano in fondo a un’acqua impetuosa, o bruciano nel fuoco, la colpa che le infettò. Ognuno soffre il destino che gli compete. Dopo siamo mandati in Eliso, ma rimaniamo in pochi nei vasti campi ridenti, finché lo scorrer di giorni, chiuso il giro del tempo, abbia tolto ogni macchia e abbia lasciato puro lo spirito celeste, la scintilla del soffio primitivo. Quelle anime che vedi, invece, dopo mille anni d’attesa, un Dio le chiama al Lete in schiera immensa, perché bevano oblio e dimentiche del passato rivedano il cielo convesso, le punga il desiderio di tornare nei corpi.” Ciò detto Anchise condusse il figlio e la Sibilla in mezzo alla folla rumorosa delle anime, guadagnando un’altura da cui veder passare tutti in fila, uno a uno, distinguendone il volto. “Ascolta, ti dirò la gloria futura della stirpe di Dardano, ti mostrerò i nipoti che ci darà l’Italia: grandi anime fatali destinate a portare un giorno il nostro nome. Quel giovane lontano (lo vedi?), che s’appoggia a un’asta senza ferro, è Silvio, nome albano, il tuo ultimo figlio. La sorte gli ha assegnato i luoghi più vicini alla luce, verrà pe primo al mondo, di sangue italico e troiano. Nascerà da te vecchio e da tua moglie Lavinia, sarà allevato nei boschi, re e padre di re, la stirpe da lui sorta dominerà Alba Longa. L’anima più vicina a lui è Proca, gloria del popolo troiano; e poi ci sono Capi, Numitore, Enea Silvio che avrà il tuo stesso nome, illustre per pietà e per valore quando potrà regnare su Alba. Guarda che giovani, guarda come appaiono forti! Guarda le loro tempie come sono ombreggiate dalla corona civica! Ti fonderanno sui monti la città di Fidene, Nomento e Gabi, le rocche Collatine, Pomezia e la fortezza d’Inuo, le grandi Bola e Cora: oggi luoghi deserti, ma un giorno avranno un nome. Fa compagnia al suo avo Romolo, figlio di Marte, che nascerà da una madre tenera del sangue d’Assaraco. Vedi come due creste gli oscillano sull’elmo, come lo stesso Padre lo consacra divino? Sarà lui a fondare quella Roma famosa che estenderà il suo impero sopra tutta la terra, che innalzerà la sua anima grande sino all’Olimpo, circondando di mura ben sette colli. Madre fortunata d’eroi! Così la berecinzia Cibele, incoronata di torri, trasportata sul suo carro, attraversa le città della Frigia, lieta della sua prole divina, felice di abbracciare i suoi cento nipoti, tutti Celesti, tutti abitanti delle alte regioni dell’aria. Ora guarda laggiù, osserva i tuoi Romani. I tuoi Romani! C’è Cesare e tutta la progenie di Iulo, che un giorno uscirà sotto la volta del cielo.
Questo è l’uomo promessoti sempre, da tanto tempo:
Cesare Augusto divino. Egli riporterà ancora una volta nel Lazio l’età dell’oro, pei campi dove un tempo regnava Saturno; estenderà il suo dominio sopra i Garamanti e gli Indi, dovunque ci sia una terra, fuori delle costellazioni, fuori di tutte le strade dell’anno e del sole, dove Atlante che porta il cielo fa roteare sulla sua spalla la volta ornata di stelle lucenti. Già sin d’ora, in attesa del suo arrivo, la terra meotica e i regni del Caspio tremano per i responsi degli Dei, e si turbano le trepide foci del Nilo dai sette rami. Nemmeno Ercole ha percorso tanto spazio di terra, sebbene trafiggesse la cerva dai piedi di bronzo e rendesse sicuri i boschi d’Erimanto e atterrisse con l’arco Lerna; nemmeno Bacco che vittorioso guida il carro con le redini intrecciate di pampini, calando con le sue tigri dall’alta vetta di Nisa. E tu esiti ancora a accrescere di tanto la nostra forza, temi di fermarti in Italia?
Chi è quell’alto eroe incoronato di olivo
che porta gli arredi sacri? Riconosco
i capelli e la barba canuta del re
che consoliderà la Roma primitiva
con le sue leggi, arrivato dalla piccola Curi e da una povera terra sino al potere supremo. Gli succederà Tullo, che interromperà gli ozi della patria e richiamerà alle armi i cittadini rilassati e le schiere disavvezze ai trionfi. Poi viene Anco Marzio ambizioso, che sembra godere già da adesso, sin troppo, del favore popolare. Ma vuoi vedere i re Tarquini e l’anima superba di Bruto vendicatore, i fasci riconquistati?
Egli sarà il primo a avere l’autorità
di console, le scuri crudeli, e punirà
di propria mano i figli (che tramavano guerra per riportare al trono i Tarquini) in difesa della libertà bella: infelice, comunque i posteri debbano giudicare quest’atto! Vincerà l’amor patrio e la brama di gloria. Guarda lontano i Deci, i Drusi, Torquato dalla tremenda scure, Camillo che riporta le insegne già predate dai Galli vittoriosi!
E quelle anime che vedi splendere in armi eguali
– ora, e finché la notte le opprimerà, concordi – quando avranno toccato la luce della vita che grande guerra, quanti massacri e quante lotte desteranno tra loro! Il suocero scendendo dai baluardi alpini e dalla rocca di Monaco, il genero appoggiato dalle forze d’Oriente. O figli, non indurite l’animo in simili guerre, non volgete le armi al cuore della patria: e tu per primo, tu che discendi dall’Olimpo, tu sangue mio, perdona, getta le armi di mano!… Ma ecco chi spingerà vittorioso il suo carro all’alto Campidoglio, dopo aver debellato Corinto, glorioso per i Greci uccisi.
Quell’altro abbatterà Argo, l’Agamennonia Micene e lo stesso Perseo Eacide, disceso dal poderoso Achille, vendicando gli avi di Troia e i profanati santuari di Minerva. Chi potrebbe tacere di te, grande Catone, o di te, Cosso? Chi potrebbe dimenticare la gran razza dei Gracchi, o i due Scipioni, fulmini di guerra, flagello della Libia, o Fabrizio parsimonioso, o Serrano che semina il suo campo? Troppo a lungo ho parlato, ma non posso tacere la vostra gloria, o Fabi! Sei proprio tu quel Massimo che, temporeggiando, da solo ha salvato lo Stato? Altri (io non ne dubito) sapranno meglio plasmare statue di bronzo che paiano respirare, o scolpire immagini viventi nel marmo; sapranno difendere con oratoria più acuta le cause legali, sapranno tracciare i moti del cielo col compasso e predire il sorgere degli astri: ma tu, Romano, ricorda di governare i popoli con ferme leggi (queste saranno le tue arti), imporre la tua pace al mondo, perdonare agli sconfitti, ai deboli e domare i superbi!” Così parlava Anchise; e ancora aggiunge, ai due che stupiti ascoltavano: “Guarda, come s’avanza Marcello, come spicca per le spoglie preziose e vittorioso eccelle su tutti gli altri eroi. Difenderà lo Stato nel più serio pericolo, grande sul suo cavallo sterminerà i nemici Cartaginesi e i Galli ribelli, appenderà tre volte le prede di guerra nel tempio di Quirino.” E allora Enea che vedeva andare insieme a Marcello un giovine bellissimo, dalle armi splendenti, ma scuro in volto, con gli occhi bassi, privi di gioia:
“Padre, chi è quel giovane che accompagna l’eroe?
Forse suo figlio, forse qualcuno dei suoi nipoti? Che murmure di meraviglia lo circonda! E che aspetto maestoso lo distingue! Ma una notte scurissima circonda la sua testa con un’ombra luttuosa.”
Il padre Anchise, gli occhi pieni di pianto, disse:
“Non domandarmi di questo futuro immenso lutto. Il Fato lo mostrerà appena al mondo e vorrà che non viva più oltre. Dei, la stirpe romana vi sembrerebbe forse troppo grande e potente se un simile miracolo dovesse durare a lungo. Quanti pianti dal Campo Marzio si leveranno alla città di Marte! E quali funerali vedrai, o padre Tevere, scorrendo davanti al nuovo sepolcro! Nessun altro figlio di gente troiana farà sperare tanto gli avi latini; e la terra di Romolo mai più potrà un giorno vantarsi altrettanto. O pietà, fede antica, invincibile mano di combattente! Nessuno avrebbe potuto impunemente affrontarlo in armi, sia che andasse contro il nemico a piedi, sia che desse di sprone a un focoso cavallo. Ohimè, fanciullo degno di pietà, se potrai forzare in qualche modo il destino crudele, sarai un degno Marcello! Spargete a piene mani gigli candidi, datemi fiori purpurei, che io possa gettarli ai suoi piedi e almeno con questi doni colmare l’anima del mio nipote, rendendogli un inutile omaggio.” Così errano qua e là per tutta la regione nei vasti campi ariosi, osservando ogni cosa. Anchise, condotto il figlio dovunque e accesagli l’anima della sua gloria futura, gli rivela le guerre che dovrà sostenere e lo informa dei popoli che lo attendono in armi, della città murata di Laurento e del re Latino: poi gli spiega in che modo sfuggire o superare i travagli. Due sono le porte del Sonno: si dice che l’una sia di corno (ed escono da essa facilmente quei sogni che si dimostrano veri), l’altra è fatta d’avorio, splendida, ma di qui i Mani spediscono in terra soltanto sogni falsi. Anchise accompagna il figlio insieme alla Sibilla e li lascia andar via dalla porta d’avorio. Enea corre alle navi e rivede i compagni. Costeggiando la riva vanno in favore di vento al porto di Gaeta, dove gettano l’ancora dalle prue, allineando le poppe sulla spiaggia.